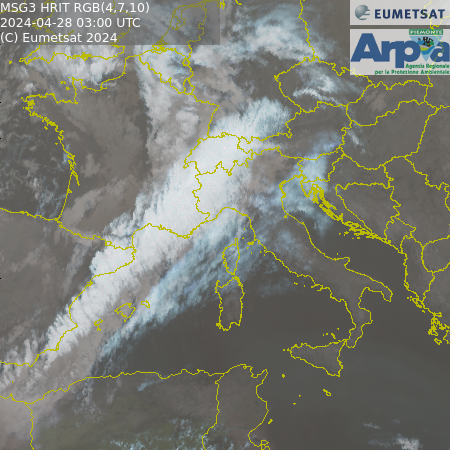- Costi
- Scuola di volo
- Flotta
- Aero Club Informa
- Monografie
- La storia
- Copertina Libro
- Cap.1 - La preistoria
- Cap.2 - Le origini del volo in Italia
- Cap.3 - La nascita delle industrie aeronautiche torinesi
- Cap.4 - I primi aeroporti piemontesi
- Cap.5 - L'aeroporto di Mirafiori
- Cap.6 - L'industria aeronautica e la grande guerra
- Cap.7 - La nascita dell'aeroporto "Torino-Aeritalia"
- Cap.8 - Gli anni d'oro
- Cap.9 - La nascita del volo a vela a Torino
- Cap.10 - La seconda guerra mondiale
- Cap.11 - Il dopoguerra
- Cap.12 - Gli anni '50 e '60
- Cap.13 - Carabinieri aviatori a Torino
- Cap.14 - Il dopo Agnelli
- Cap.15 - Il giro di boa e i nuovi investimenti
- Cap.16 - Il tempo presente
- Cap.17 - Le olimpiadi del volo: world air games 2009 (WAG)
- Cap.18 - L'avventura spaziale di Torino
- Cap.19 - Cento anni di storia dell'aeroporto Torino-Aeritalia
- Cap.20 - Gli eventi recenti
- Cap.21 - I presidenti dell'aero club torino
- Tabelle
- Bibliografia
Capitolo 7. La nascita dell’aeroporto “Torino-Aeritalia”
 Manifesto delle Industrie Pomilio
Manifesto delle Industrie Pomilio
Il 9 gennaio 1916 nacque in Torino, corso Francia 366, la “Soc. Anonima Costruzioni Aeronautiche ing. O. Pomilio & C.”.
Fondatore fu l’ingegner Ottorino Pomilio che era un apprezzato ingegnere della DTAM (Direzione Tecnica Aviazione Militare) dove, insieme all’ingegnere Umberto Savoia, aveva iniziato la progettazione dei velivoli “SP” (Savoia-Pomilio).

|
L’ingegner Corradino d’Ascanio, collaboratore e |
Nel 1915 si dimise dalla DTAM per iniziare in proprio l’attività industriale finalizzata a sviluppare e produrre gli SP.2 per cui nel gennaio successivo, in pieno svolgimento della Prima guerra mondiale, fondò l’azienda che diverrà ben presto una importante realtà industriale torinese al punto che nel 1917 supererà il numero di 1.000 dipendenti.
Tra i collaboratori di eccellenza di cui Pomilio si avvalse vi fu anche un abruzzese come lui, l’allora tenente di complemento ingegnere Corradino D’Ascanio, che sarà a sua volta un grande pioniere dell’aviazione italiana.
|
|
|
 22 ottobre 1917. Aeroporto di Mineola (Usa), il pilota Baldioli accolto dagli aviatori americani
22 ottobre 1917. Aeroporto di Mineola (Usa), il pilota Baldioli accolto dagli aviatori americani
al termine del raid Langley (Virginia)-New York
D’Ascanio collaborò infatti con Pomilio alla progettazione di aerei da caccia e bombardamento che poi fronteggiarono l’aviazione austriaca dopo la disfatta di Caporetto e gli cedette il brevetto n. 32.500 del 30 giugno 1916 del “Clinometro universale automatico per aeroplani e simili che ha lo scopo di fornire sulle macchine volanti, particolarmente sugli aeroplani, uno strumento il quale indichi automaticamente ad ogni istante l’inclinazione dell’aeroplano tanto longitudinale, per spostamento di beccheggio, quanto laterale se questa è viziosa”, un precursore dell’orizzonte artificiale. Le maestranze della Pomilio superarono il numero di 1.000 unità con una produzione di oltre 150 velivoli al mese
Le maestranze della Pomilio superarono il numero di 1.000 unità con una produzione di oltre 150 velivoli al mese
D’Ascanio (che diventerà famoso in tutto il mondo come progettista del moto-scooter “Vespa”) è considerato il padre Italiano degli elicotteri. I suoi studi sul volo verticale lo portarono, il 27 aprile 1925, a brevettare l’elicottero d’A.T1 a due eliche coassiali costruito dalla ditta Camplone di Pescara.
Nel 1917 Pomilio iniziò la progettazione del biposto da caccia “C.1” e fino al giugno del 1917, anno in cui cessò la produzione, ne uscirono circa 80 esemplari. In seguito i velivoli Pomilio vennero contrassegnati dalla lettera “P”.
Il 10 luglio 1916 per il collaudo dei suoi velivoli, inaugurò quello che è oggi conosciuto come “Aeroporto Torino-Aeritalia”, prospiciente allo stabilimento di corso Francia, con il volo del prototipo del velivolo militare SP.2, pilotato dal sergente Almerigi.
Dopo la versione “C” uscirono le versioni “P.D” - “P.E” che nel 1917 vennero anche inviate negli Stati Uniti al fine di effettuarne la presentazione alle autorità militari, Il modello “P.E” ottenne lusinghieri risultati stabilendo il record di velocità americano di quell’epoca, con una velocità di 210 km/h su un percorso di 480 km (pilota Baldioli, motorista Zappa).
Per il modello “P.E” gli stabilimenti di corso Francia giunsero ad una produzione di oltre 150 velivoli/mese.
Nel 1918 Pomilio era pronto per il collaudo di un velivolo progettato e prodotto nel più rigoroso segreto che assunse la denominazione di “P. Gamma”. Era un biplano monoposto con ottime doti acrobatiche che fu anche prodotto in piccola serie con motore if (Isotta Fraschini). Il P. Gamma fu presentato alla Commissione Militare sul campo di Mirafiori dal pilota Mario De Bernardi, ma non ebbe l’atteso successo.
L’ultimo progetto di Pomilio fu il modello “P.F” messo a punto nel 1918 che non arrivò mai alla produzione in quanto nell’estate di quell’anno la proprietà passò all’Ansaldo con il nome di “SAI – Gio-Ansaldo & C. – Cantiere Aeronautico n. 5”. Sino ad allora la Pomilio aveva prodotto oltre 1.200 velivoli.
Con la “Pomilio” è così iniziata la lunga avventura di quello che con il nome di “Torino-Aeritalia” diventerà negli anni dal ’45 al ’53 il principale aeroporto di Torino e che tanta parte ha avuto, e continua ad avere, nella storia aeronautica di Torino.
L’aeroporto dell’Aeritalia diventò anche un polo di attrazione che non disdegnava eventi aeronautici mondani.a“La Domenica del Corriere” del 14 luglio 1929 diede, ad esempio, ampio spazio al volo da Torino a Milano della duchessa d’Aosta, della duchessa Elena di Francia e del suo marito duca delle Puglie effettuato su un FIAT AS.1 ai comandi e con il coordinamento, del pilota Arturo Ferrarin.
|
|
|
|
|

Corradino D’AscanioPopoli (PE) 1° febbraio 1891 – Pisa 5 agosto 1981
Elicotteri |
 Illustrazione di Achille Beltrame su “La DomenicaIllustrazione di Achille Beltrame su “La Domenicadel Corriere” Illustrazione di Achille Beltrame su “La DomenicaIllustrazione di Achille Beltrame su “La Domenicadel Corriere” |
L’elica a passo variabile
 Grazie alle sue esperienze con l’elicottero, D’Ascanio divenne il massimo esperto italiano di eliche a passo variabile e per sua fortuna l’invenzione gli consentì di recuperare la perduta tranquillità economica.
Grazie alle sue esperienze con l’elicottero, D’Ascanio divenne il massimo esperto italiano di eliche a passo variabile e per sua fortuna l’invenzione gli consentì di recuperare la perduta tranquillità economica.
A quel tempo l’industria aeronautica, a causa delle crescenti potenze dei motori degli aerei, iniziava ad avere bisogno di disporre dell’elica a passo variabile o a giri costanti.
Fu quindi grazie alle competenze maturate con il D’AT.3 che su D’Ascanio si concentrarono le attenzioni della sezione aeronautica della Società Rinaldo Piaggio con la quale, a partire dal 1932, D’Ascanio cominciò a collaborare.
La richiesta di eliche a passo variabile ebbe un notevole incremento negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale in quanto furono montate su molti aerei italiani tra cui Macchi e Caproni.
Nel 1935 D’Ascanio progettò un nuovo elicottero per il Ministero dell’Aeronautica, il PD.2 (Piaggio-D’Ascanio2) seguito nel 1939 dal PD.3 che aveva un solo rotore e l’elica di contro coppia, in una configurazione che rispetta quella dei moderni elicotteri.
Il suo sviluppo andava a rilento e si fermò del tutto con lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Fu provato in volo solo nel 1942, ma rimase alla fase sperimentale.
Nel 1951 la Piaggio pensò di riprendere la produzione di elicotteri e avviò la costruzione del P.D.4 (Piaggio-D’Ascanio 4) dotato di due rotori, ma a seguito di un incidente in fase di collaudo accantonò definitivamente il progetto.
|
|
La “Vespa”
Con la fine della Seconda guerra mondiale c’era da risolvere il problema della riconversione degli stabilimenti ad una produzione di pace.
Enrico Piaggio ebbe la geniale intuizione di costruire un motociclo, a basso costo, accessibile a tutti e nell’estate del 1945 affidò l’incaricò a D’Ascanio che affrontò il problema con una mentalità del tutto nuova.
D’Ascanio non amava le motociclette, non se n’era mai occupato dal punto di vista costruttivo e come veicolo non gli piaceva. Pensò a un mezzo per chi non era mai salito su una motocicletta e odiava la sua guida difficile: ideò così la “Vespa” che fece la sua comparsa ufficiale nel 1946 quando venne esposta al salone del ciclo e motociclo di Milano e fu subito un successo. Ma questa e un’altra storia.
 Piaggio Vespa 98CC del 1946 ⁄ Piaggio Vespa 98CC of 1946 Piaggio Vespa 98CC del 1946 ⁄ Piaggio Vespa 98CC of 1946 |
Mario De Bernardi
Nel 1926 partecipò alla nona edizione della Coppa Schneider che quell’anno si svolse a Hampton Roads, in Virginia (Stati Uniti). La Coppa Schneider era una gara di velocità per idrovolanti. Gli aerei compivano un percorso su circuito triangolare. Tale competizione era stata ideata dall’ingegnere francese Jaques Schneider nel 1913, per favorire il progresso tecnologico soprattutto in campo motoristico. Il 13 novembre De Bernardi, ai comandi di un idrocorsa Macchi M.39, vinse la competizione percorrendo i 350 km del circuito alla media di 396,7 km/h e stabilendo il nuovo record mondiale di velocità per idrovolanti. Pochi giorni più tardi, sul medesimo aereo, riuscì a migliorare ulteriormente il suo stesso primato.
Nel 1928, con un idrocorsa Macchi M.52R, fu il primo uomo a superare la velocità di 500 km/h, raggiungendo i 512,776 km/h. Nel 1931 vinse a Cleveland le gare di acrobazia del National Air Races. Nel 1940-41 fu il primo italiano a pilotare un aeroplano a reazione Caproni-Campini N.1/C.C.2. |
Il primo volo postale
Il primo esperimento ufficiale di posta aerea tra Torino e Roma era pianificato per le 6 del 20 maggio 1917.
L’articolo di quel giorno pubblicato su “La Stampa” riportava:
“[…] Il sindaco , conte senatore Teofilo Rossi invierà a Sua Eccellenza Boselli, al Sindaco di Roma ed al Ministro delle Poste e Telegrafi un messaggio augurale, che recherà alla capitale il saluto e l’omaggio dell’amministrazione civica e della cittadinanza torinese”.
 Purtroppo il maltempo impedì lo svolgimento dell’evento e “La Stampa” del 21 maggio a pagina 2 così commenta:
Purtroppo il maltempo impedì lo svolgimento dell’evento e “La Stampa” del 21 maggio a pagina 2 così commenta:
“La pioggia dirottisima ha impedito ieri mattina il primo esperimento di posta aerea Torino-Roma, guastando, naturalmente, la mattutina cerimonia inaugurale. Il Pilota tenente De Bernardi ha dovuto rimandare il suo raid in attesa di miglior tempo”.
Finalmente il tempo migliorò e il 23 maggio 1917 alle 11,27, decollando dal campo della Pomilio (oggi Aeritalia), venne inaugurato il primo volo postale italiano. Ai comandi del tenente Mario De Bernardi (collaudatore della Pomilio) il velivolo p.c (Pomilio Caccia) con a bordo 200 chili di posta e 100 copie de “La Stampa”, atterrò con qualche problema alle ore 15,30, dopo 4 ore e 3 minuti all’aeroporto di Centocelle a Roma alla presenza delle autorità civili e militari.
La puntuale cronaca de “La Stampa” riporta i seguenti passi:
“[…] era atteso […] da una grande ed elegante folla trattenuta da cordoni di carabinieri a piedi e a cavallo […]. Quando l’apparecchio apparve sopra il campo […] compì un’ardita evoluzione e quindi atterrò. In quest’ultima manovra si inalberò posteriormente riportando danni all’elica e al carrello […] ma subito si apprese che l’aviatore era perfettamente incolume e che anche i danni all’apparecchio erano minimi […].”
[…] Il tenente De Bernardi dopo il breve ricevimento, è salito in automobile recandosi dal presidente del Consiglio Boselli, per il quale era latore di una targa e dei messaggi delle autorità […] di Torino”.
|
|
|
|
|
|
“Appena iniziato il volo puntai su Superga e incontrai subito un forte vento, ma tuttavia posi il mio apparecchio alla velocità di 180 Km all’ora […] Sorpassai la catena dei Giovi all’altezza di 2.000 metri con forte vento e pioggia e sono quindi disceso a minor altezza costeggiando il mare. Il viaggio procedette in discrete condizioni fino verso Pisa. Qui le condizioni atmosferiche resero difficilissima la prosecuzione del viaggio. Il vento e la pioggia intensissima mi imposero il dilemma o d’atterrare oppure mutare rotta. Preferii mutare il percorso stabilito compiendo una leggera deviazione […]. Alle 15,21 mi trovavo al di sopra di Roma che attraversai a bassa quota. Alle 15,28 giungevo al campo di Centocelle dove atterrai […]”.
All’impresa le Poste Italiane dedicarono una sovrastampa speciale sul francobollo da “25 cent. Espresso”.

 Come detto, nel 1918 la Società Pomilio e l’annesso campo volo vennero ceduti all’Ansaldo e da questa passati più tardi (1926) alla FIAT, che denominò questo complesso “FIAT Aeronautica d’Italia s.a.” da cui, nel tempo, l’abbreviazione “Aeritalia”. All’epoca la FIAT completò il binomio Terra-Mare con la parola Cielo. Il cielo più importante era quello dell’Aeritalia.
Come detto, nel 1918 la Società Pomilio e l’annesso campo volo vennero ceduti all’Ansaldo e da questa passati più tardi (1926) alla FIAT, che denominò questo complesso “FIAT Aeronautica d’Italia s.a.” da cui, nel tempo, l’abbreviazione “Aeritalia”. All’epoca la FIAT completò il binomio Terra-Mare con la parola Cielo. Il cielo più importante era quello dell’Aeritalia.
 1928. Aeroporto Torino Aeritalia. Riunione del presidente e delle maestranze. Si riconoscono, tra gli altri (da sinistra): capitano Bedendo, Donati, ingegner Nuvoli, capitano Brach Papa. Lovadina, Ferrarin, Cobianchi, colonnello Bolognesi e i tenenti Cassinelli, Bertolini e Ranieri. Al centro una missione francese. Sullo sfondo il sesquiplano Bréguet XIX, due BR-1 e un CR-1
1928. Aeroporto Torino Aeritalia. Riunione del presidente e delle maestranze. Si riconoscono, tra gli altri (da sinistra): capitano Bedendo, Donati, ingegner Nuvoli, capitano Brach Papa. Lovadina, Ferrarin, Cobianchi, colonnello Bolognesi e i tenenti Cassinelli, Bertolini e Ranieri. Al centro una missione francese. Sullo sfondo il sesquiplano Bréguet XIX, due BR-1 e un CR-1
 |
Vai al Capitolo Successivo |
LINK
AERO CLUB TORINO
- Strada della Berlia 500
Torino - +39 011.7790916
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Piazzale Volo a motore:
+39 348.0448082
Piazzale Volo a vela:
+39 335.1008670
Officina ASI: +39 011.710080
Ristorante Campo Volo:
+39 011.7725989
2021 © Aero Club Torino - Tutti i diritti riservati - CF: 01395280017 - Credits
CREDITS
Progettazione e realizzazione sito web
vg59* Progetti Multimediali



 Officine Pomilio: l’SP.3 in allestimento
Officine Pomilio: l’SP.3 in allestimento Officine Pomilio: assemblaggio della carlinga SP.2
Officine Pomilio: assemblaggio della carlinga SP.2



 Luglio 1929 - La duchessa d’Aosta, la duchessa Elena di Francia e il marito il duca delle Puglie si preparano al volo sul Campo dell’Aeronautica d’Italia
Luglio 1929 - La duchessa d’Aosta, la duchessa Elena di Francia e il marito il duca delle Puglie si preparano al volo sul Campo dell’Aeronautica d’Italia Pomilio S.P3
Pomilio S.P3 Pomilio P.D
Pomilio P.D


 Nel mondo aeronautico D’Ascanio è da tutti conosciuto come il padre degli elicotteri italiani, ma per sua fortuna (economica) divenne famoso nel mondo per essere stato il creatore della “Vespa”.
Nel mondo aeronautico D’Ascanio è da tutti conosciuto come il padre degli elicotteri italiani, ma per sua fortuna (economica) divenne famoso nel mondo per essere stato il creatore della “Vespa”.
 1951. Elicottero sperimentale Piaggio P.D.4 in volo di collaudo sul Campo della Piaggio di Pontedera
1951. Elicottero sperimentale Piaggio P.D.4 in volo di collaudo sul Campo della Piaggio di Pontedera Mario De Bernardi con il P.Gamma IF
Mario De Bernardi con il P.Gamma IF  5 maggio 1925. Mario De Bernardi su a
5 maggio 1925. Mario De Bernardi su a

 Il tenente Mario De Bernardi a bordo del Pomilio P.C.
Il tenente Mario De Bernardi a bordo del Pomilio P.C. Il secondo arrivo a Roma Centocelle di Mario De Bernardi a bordo
Il secondo arrivo a Roma Centocelle di Mario De Bernardi a bordo